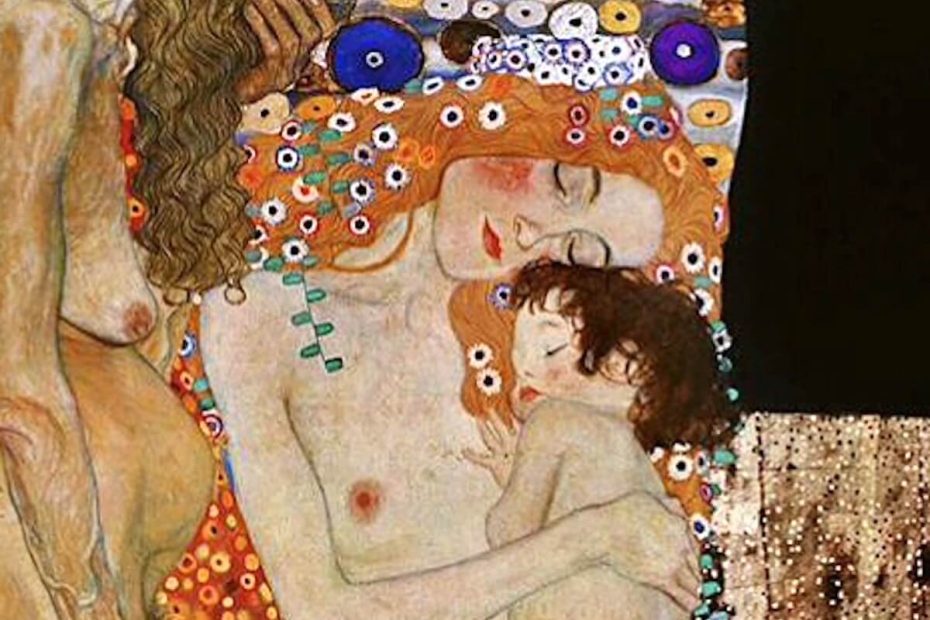Il tema del divieto della maternità surrogata (o gestazione per altri), posto dall’art. 12, comma 6°, della Legge 40/2004, è da sempre al centro di un vivace dibattito in giurisprudenza e in dottrina, riguardando diritti fondamentali della persona umana ed investendo questioni estremamente delicate come quella della filiazione delle coppie dello stesso sesso, anch’essa esclusa nel nostro ordinamento.
L’argomento è tornato di estrema attualità negli ultimi giorni, a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 1842, del 21 gennaio 2022, della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha investito il Primo Presidente della opportunità di rimettere alle Sezioni Unite, come questione di particolare rilevanza, quella del riconoscimento dell’atto di nascita estero di minore nato mediante ricorso alla gestazione per altri, da parte del genitore non biologico (nel caso di specie, in coppia omogenitoriale maschile).
La questione era già stata oggetto di un intervento delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 12193/2019, avevano posto fine all’insorto contrasto giurisprudenziale, sancendo la non riconoscibilità nel nostro ordinamento del provvedimento amministrativo o giurisdizionale straniero che attribuisca lo stato di figlio ad un bambino nato in seguito a gestazione per altri in un paese in cui tale pratica è consentita rispetto al genitore d’intenzione (ossia quello non biologico), a causa del divieto assoluto di maternità surrogata previsto dal citato art. 12, comma 6°, Legge 40/2004, qualificato dalle SS.UU. come espressione del principio di ordine pubblico in quanto posto a tutela di valori fondamentali, come la dignità della gestante, ed individuando nella “adozione in casi particolari”, di cui all’art. 44, comma 1, lett. d), della Legge 184/1983 lo strumento per il riconoscimento dello status filiationis del minore nel rapporto con il genitore d’intenzione.
Secondo la lettura di autorevoli interpreti, la soluzione offerta dalle SS.UU. costituiva, ad ordinamento invariato, il miglior punto di equilibrio tra la tutela degli interessi della gestante, massimamente protetti dal divieto di maternità surrogata introdotto dal Legislatore del 2004, e quelli del minore a non disperdere e conservare il patrimonio di affetti “familiari” costituito con l’altro genitore.
La cornice giuridica, tuttavia, è mutata per effetto della sentenza n. 31/2021 della Corte Costituzionale, investita dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione della questione di legittimità dell’art.12, comma 6, della Legge n. 40/2004, nella parte in cui non consente che possa essere riconosciuto e dichiarato esecutivo il provvedimento giudiziario straniero relativo all’inserimento nell’atto di stato civile di un minore nato da maternità surrogata del genitore intenzionale e non biologico, per contrasto con gli artt. 2, 3, 30, 31 e 117, comma 1°, della Costituzione.
La Consulta, infatti, partendo dal presupposto che in tutte le vicende giudiziarie e amministrative relative ai minori deve essere riconosciuto rilievo primario proprio all’interesse del minore, ha affermato, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU, che l’interesse prioritario del minore sia quello della conservazione di rapporti che costituiscono parte integrante del suo patrimonio affettivo e, quindi, del riconoscimento sociale e giuridico del legame con entrambi i componenti della coppia che lo hanno accudito sin dalla nascita, non ostando a ciò la circostanza che il vincolo riguardi persone dello stesso sesso, dal momento che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l’orientamento sessuale non incide di per se stesso sulla idoneità all’assunzione della responsabilità genitoriale. Tale interesse, però, secondo il Giudice delle Leggi, non è da ritenersi automaticamente prevalente e va, dunque, bilanciato, alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità attraverso la individuazione di uno strumento giuridico idoneo a contemperare entrambi gli interessi. Lo strumento adeguato, per la Consulta, non può essere “l’adozione in casi particolari”, che, come disciplinata nel nostro ordinamento, non risponde all’esigenza di tutelare gli interessi del minore ad una stabilizzazione del rapporto affettivo e giuridico con l’altro genitore poiché non garantisce all’adottante la qualifica di genitore e presuppone sempre il consenso di quello biologico. Tuttavia, la Corte, pur ritenendo fondati i rilievi contenuti nell’ordinanza di rimessione, non è pervenuta ad una sentenza di incostituzionalità sul presupposto che il compito di adeguare il diritto vivente spetti al Legislatore, sollecitato ad intervenire prontamente “nell’ormai indifferibile individuazione delle soluzioni in grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore”.
L’atavica incapacità del Legislatore nostrano ad intervenire tempestivamente anche a fronte di situazioni di estrema rilevanza sociale, ancor prima che giuridica, ha posto le condizioni per la recentissima ordinanza interlocutoria della Prima Sezione Civile, che ha invocato un nuovo intervento nomofilattico delle SS.UU. al fine di verificare se, e come, sia superabile in via interpretativa, la situazione di vuoto normativo determinato dal pronunciamento della Corte Costituzionale, che, ritenendo inadeguata la soluzione offerta dall’istituto della “adozione in casi particolari”, ha demolito il punto di equilibrio sul quale era incentrato il diritto vivente rappresentato dalla sentenza n. 12193/2019 delle Sezioni Unite, che deve ritenersi ormai archiviato. La soluzione prospettata dall’ordinanza interlocutoria in commento è quella di ritenere superato il divieto generalizzato di trascrizione dell’atto di nascita in Italia in quanto non afferente all’ordine pubblico, non essendo in discussione il divieto di maternità surrogata ma la tutela degli interessi del minore, consentendone, quindi, la trascrizione previa valutazione legata al singolo caso concreto da parte del Giudice investito della delibazione della sentenza straniera, secondo criteri di inerenza, proporzionalità e ragionevolezza per come affermati dalla giurisprudenza costituzionale nell’ottica della ricerca della soluzione ottimale in concreto per l’interesse del minore. Nell’ambito di tale valutazione caso per caso andranno messi a confronto, in concreto, l’interesse del minore a che vengano rispettati i suoi diritti fondamentali alla identità personale e alla vita familiare con la tutela della dignità della donna coinvolta nel processo procreativo mediante gestazione per altri, di cui deve essere valutata l’adesione libera, consapevole e non determinata da necessità economiche e la revocabilità del consenso alla rinuncia all’instaurazione del rapporto di filiazione sino alla nascita del bambino e ferma restando la necessità di un apporto genetico alla procreazione da parte di almeno uno dei due genitori intenzionali.
Non ci resta che attendere la pronuncia delle Sezioni Unite, che potrebbe segnare un punto di svolta in attesa che il Legislatore, destandosi dal suo torpore, colmi la lacuna normativa mediante la individuazione di strumenti giuridici adeguati a proteggere e garantire i diritti fondamentali dei due soggetti di cui l’ordinamento deve farsi carico: il minore e la madre naturale.
Alessandro Scalia – socio fondatore dell’Unione Avvocatura Siciliana