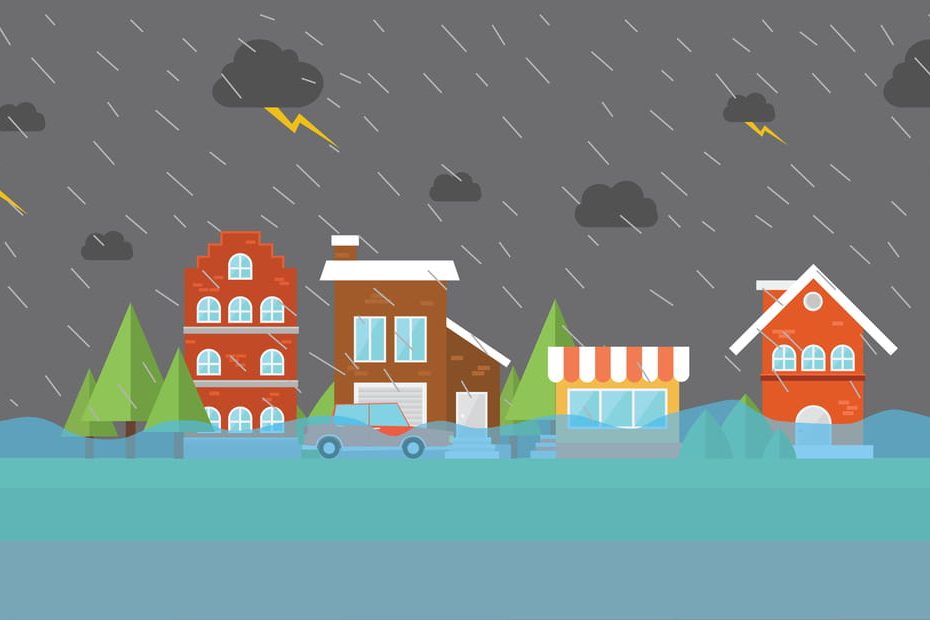I nostri Tribunali sono ormai inondati (è proprio il caso di dirlo) dalle azioni risarcitorie proposte da proprietari di immobili e utenti delle strade, che lamentano danni in conseguenza dei nubifragi che, sempre più frequentemente, si abbattono sulle aree urbane.
Nella quasi totalità dei casi, i danneggiati agiscono nei confronti degli enti territoriali, nella loro veste di custodi delle strade da cui provengono le acque meteoriche e delle opere di urbanizzazione primaria di cui lamentano il mal funzionamento o, comunque, l’inidoneità ad evitare l’evento dannoso.
In altri casi, le pretese risarcitorie sono rivolte dai conduttori degli immobili nei confronti dei locatori o dagli attuali proprietari nei confronti dei loro danti causa o dei costruttori degli immobili: anche in tali ipotesi, tuttavia, è scontato il coinvolgimento dell’ente locale nel giudizio a seguito della chiamata in causa da parte del convenuto.
A fondamento delle domande proposte nei confronti degli enti pubblici da parte del danneggiato (o del convenuto che agisca in garanzia) viene invocata la responsabilità del custode delle strade e degli impianti di smaltimento delle acque pluviali, al fine di usufruire del più agevole regime probatorio previsto dall’art. 2051 c.c..
D’altra parte, la linea difensiva dell’ente locale convenuto o terzo chiamato è quella di invocare il caso fortuito, da individuarsi nella eccezionalità dell’evento meteorico.
Com’è noto, infatti, il danneggiato che agisce nei confronti del custode deve limitarsi a provare il fatto lesivo come verificatosi in concreto, il nesso causale tra la cosa in custodia e il medesimo evento lesivo, nonché il danno conseguenza, spettando al custode, che voglia liberarsi dalla sua responsabilità, provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso eziologico.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, consolidatosi a partire dalle ordinanze del 1° febbraio 2018, da n. da 2477 a n. 2483, l’istituto del danno da custodia ha, dunque, un carattere puramente oggettivo, esulando dalla sua struttura qualsivoglia connotazione che attenga alla colpevolezza del custode.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, regole tecniche o criteri di comune prudenza da parte del custode, invero, rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere e provare, cioè, il rapporto causale tra quella e l’evento dannoso
Facendo rigorosa applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un comune della Provincia di Brindisi avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, riformando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda proposta dal proprietario di un immobile che lamentava di aver subito danni a seguito di un allagamento dovuto al riversamento delle acque meteoriche provenienti dalla strade limitrofe.
La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto responsabile l’ente territoriale (in solido con la società costruttrice dell’immobile) sulla scorta dell’indagine tecnica espletata in corso di causa dalla quale era emerso che «l’accurata descrizione dei luoghi e degli inidonei o, meglio, degli inesistenti sistemi di deflusso» consentivano di «escludere l’efficacia causale esclusiva delle precipitazioni», non essendo stata fornita la prova, gravante sul custode, che questi avesse mantenuto una condotta diligente nel caso concreto.
Ebbene, la Terza Sezione, con l’ordinanza n. 4588, dell’11 febbraio 2022, nel cassare la sentenza del Giudice di seconde cure, ha chiarito che «al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell’anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., la distinzione tra “forte temporale”, “nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili».
In tale ottica, dunque, «l’accertamento del fortuito, rappresentato dall’evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico (in particolare, i dati c.d. pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia», dati obiettivi, quindi, «ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioè dal custode), riferiti ad un lasso temporale amplissimo – quanto meno di numerosi decenni – e non limitato all’angusto intervallo preso in considerazione».
Da detta indagine, secondo gli Ermellini, al contrario di quanto affermato nella sentenza cassata, devono rimanere estranei i profili inerenti alla colpa del custode nella predisposizione di cautele (specifiche e/o generiche) atte a rendere la res idonea a non arrecare pregiudizio, con la conseguenza che ogni allegazione attinente allo «stato» del sistema di smaltimento delle acque meteoriche diviene inconducente, a meno che non rilevi ai fini della dimostrazione del nesso causale tra la res medesima e l’evento lesivo.
Ovviamente, nulla impedisce al danneggiato (o al chiamante in garanzia) di agire in via principale o anche in linea subordinata ai sensi dell’art. 2043 c.c., invocando a fondamento della sua azione la negligenza dell’ente e, quindi, l’inidoneità del sistema di deflusso in relazione allo specifico evento meteorico ma, in quel caso, sarà onere di chi agisce allegare e provare la colpevolezza dell’ente territoriale mediante indagini tecniche onerose e dall’esito incerto.
Avv. Alessandro Scalia – socio fondatore Unione Avvocatura Siciliana.